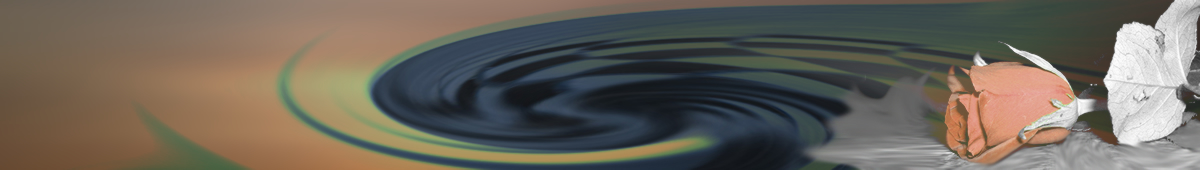di Silvia Lo Vetere
La medicina, nell’arco di pochi decenni, sembra aver compiuto miracoli (o almeno così pare ad un occhiata superficiale): la verità è che le malattie sono in aumento, soprattutto quelle neurodegenerative; oggi però si prevengono, si diagnosticano precocemente, sono più curabili e consentono potenzialmente una vita più lunga.
 Le “nuove genitorialità”
Le “nuove genitorialità”
Purtroppo i risvolti di questo allungamento della vita non sono solo positivi. Allungandosi la vita, sono anche aumentate le malattie croniche e quindi i bisogni di cura e di assistenza si sviluppano oggi in un arco di tempo ineditamente allungato. Proprio in questo contesto, nasce un vero e proprio tipo nuovo di genitorialità: quella che vede sempre più figli, su per giù arrivati alla soglia della cinquantina, assistere e curare i propri genitori che si ammalano e perdono autonomia, per tempi potenzialmente protratti, mai esistiti nella storia dell’umanità.
Figli che si trovano ad assumere quindi nei loro confronti, crescenti funzioni di tutela, di guida e di decisionalità. Figli che, in sostanza, diventano genitori dei propri genitori. Le implicazioni pratico-organizzative ed emotive sulle loro vite sono enormi, aggravate e acutizzate in modo esponenziale dalla carenza di aiuti istituzionali e collettivi, che lascia a loro la delega sostanziale della gestione dei numerosi aspetti che la cura comporta: medici, sanitari, assistenziali, organizzativi e in generale di supporto.
Cattive figlie?
Indiscusse protagoniste, anche se non uniche, su questa nuova scena, rimangono madri e figlie. Protagoniste delle quali ‘Virginia’ (una paziente presa come esempio per questo scritto) ci fornisce un eloquente spaccato, paradossale e drammatico. Paradossale, in una società moderna e avanzata come la nostra, se si pensa al quadro di sostanziale solitudine che Virginia trasmette; drammatico se ascoltiamo la conclusione che arriva a trarre su di sé, mentre ogni giorno cerca di rintracciare un equilibrio difficilissimo fra affetti, organizzazione e complesse decisioni da prendere: la conclusione di essere una cattiva figlia.
Come mai è Virginia, e con lei moltissime figlie che incontro sia nella mia vita privata, che nel mio lavoro di psicologa, a sentirsi sostanzialmente quasi la sola colpevole di fronte alla madre che ama e che perde forze? Addirittura arrivando al dubbio di essere una cattiva figlia? I perché sono tanti, complessi, e certo queste riflessioni non vogliono, né possono analizzarli profondamente e men che meno esaurirli.
I tanti perché
Ma alcuni “perché” appaiono di immediata osservazione:
– perché nella nostra società la famiglia continua a essere messa al centro di risposte e di soluzioni, senza una sufficiente, costante e sistematica collaborazione di altri partner istituzionali a suo sostegno: i servizi sono sporadici, le badanti vanno pagate, i ricoveri prevedono rette spesso estremamente alte. Ecco allora che un problema vasto e complesso che investe l’intera società e che non può prescindere da una ricerca di soluzioni collettive, diventa, paradossalmente, un problema personale: alla famiglia viene sostanzialmente richiesta una buona dose di creatività nella ricerca e attuazione di soluzioni, e un buon patrimonio monetario per sostenerle;
– perché famiglia, nella stragrande maggioranza dei casi, significa figlie femmine: sulle donne continua a gravare l’aspettativa non dichiarata dell’intera società, che il lavoro di cura sia di loro stretta pertinenza. Se in famiglia ci sono un fratello e una sorella, non sempre ma di frequente, si osserva alle prese con una continua, logorante e talvolta drammatica ricerca di soluzioni, la figlia femmina;
– perché spesso le donne stesse, sotto l’egida di queste aspettative, stentano a legittimare il loro grido di ribellione, contro una delega a loro dei compiti di cura, che continua ancora ad essere esclusiva e consistente.
Mai abbastanza adeguata
Per questi e per molti altri “perché”, a fare sentire una figlia inadeguata, non sono solo il dolore e l’impotenza personali di fronte a una madre che soffre. Sono anche la reale e oggettiva carenza di supporti e di aiuti con cui condividere compiti, responsabilità e anche emozioni difficili; sono le aspettative di delega nei suoi confronti ancora molto forti, quelle aspettative di una intera società, spesso pronta ad additarla come cattiva figlia se le cose non vanno per il verso giusto: poteva rinunciare ad andare al convegno, poteva sforzarsi di più, poteva essere meno egoista dopo tutto quello che sua madre ha fatto per lei, poteva ridimensionare gli impegni lavorativi; frasi che ricorrono ancora in modo non poi così raro.
 Proprio in questa situazione di solitudine e di giudizio che vede madre e figlia sostanzialmente sole sulla scena della cura, allora il senso di colpa diventa compagno costante dei pensieri di una figlia: mai abbastanza adeguata, mai abbastanza presente, con desideri talvolta di fuga non da sua madre, ma da una situazione che pesa su di lei in modo stringente. Una cosa logorante e alla lunga rischiosa. Perché quello della colpa è un sentimento che sollecita penosi sentimenti, che mina l’autostima e il valore di sé, fino a produrre, come ci dice Virginia, il dubbio di essere cattiva; cattiva con la persona che, al di là di come siano andate le cose, rimane forse, la più importante della sua vita, sua madre appunto. Una percezione dolorosa e ingiusta che produce un’altrettanto penosa e ingiusta sensazione di fallimento. Una percezione che, insieme alla stanchezza, all’impotenza, alla sofferenza, sulla lunga può diventare davvero troppo logorante e mettere a dura prova l’equilibrio psicologico di una figlia.
Proprio in questa situazione di solitudine e di giudizio che vede madre e figlia sostanzialmente sole sulla scena della cura, allora il senso di colpa diventa compagno costante dei pensieri di una figlia: mai abbastanza adeguata, mai abbastanza presente, con desideri talvolta di fuga non da sua madre, ma da una situazione che pesa su di lei in modo stringente. Una cosa logorante e alla lunga rischiosa. Perché quello della colpa è un sentimento che sollecita penosi sentimenti, che mina l’autostima e il valore di sé, fino a produrre, come ci dice Virginia, il dubbio di essere cattiva; cattiva con la persona che, al di là di come siano andate le cose, rimane forse, la più importante della sua vita, sua madre appunto. Una percezione dolorosa e ingiusta che produce un’altrettanto penosa e ingiusta sensazione di fallimento. Una percezione che, insieme alla stanchezza, all’impotenza, alla sofferenza, sulla lunga può diventare davvero troppo logorante e mettere a dura prova l’equilibrio psicologico di una figlia.
In questa situazione di forte malessere che vede coinvolte un numero crescente di figlie, un numero destinato a crescere, non si può prescindere dall’auspicare una trasformazione culturale che sembra essersi per certi aspetti fermata. Quella che vede in modo più convinto e sostanziale il lavoro di cura come impegno collettivo, non delegato in modo troppo esclusivo alla famiglia e in particolare alle donne. Nel frattempo che fare? Ben lungi dal potere e volere rispondere a questa domanda, forse qualche regola può essere utile come spunto di riflessione alle figlie che sempre più numerose affrontano questa condizione.
Non incapaci, ma pionieri
Che i figli curino i genitori in vecchiaia per un tempo divenuto, per la prima volta nella storia dell’uomo così lungo, è un fenomeno del tutto nuovo. Bisogna accettare sì la propria inevitabile e umana inadeguatezza. Non solo però come limite personale ma, soprattutto, come espressione di quel coraggio che caratterizza il pioniere che procede, senza copioni già scritti.
Da subito non essere soli
Che gli aiuti istituzionali siano carenti è un fatto osservabile e oggettivo. Quando poi anche le risorse economiche personali scarseggiano, davvero tutto diventa molto più complicato. È anche vero, però, che affetto e dolore portano, soprattutto all’inizio, ad assumere tutto si di sé, sottovalutando la quantità di energie necessaria da distribuire in un arco di tempo potenzialmente lungo. Pensare da subito in modo serio, sistematico e creativo a come condividere, almeno un po’, oneri, emozioni, strategie e responsabilità, deve diventare un compito imprescindibile. Talvolta può allora accadere che qualche risorsa che non si sarebbe mai considerata, come ad esempio un vicino, un volontario o altro, possano essere inseriti e messi in campo almeno per qualcosa. Bisogna avere sempre in mente che è assolutamente indispensabile pensarsi coinvolte in un arco di tempo lungo, nel quale servono energie e lucidità mentale per potere continuare ad aiutare chi si ama.
Mettere in campo i fratelli maschi
Che i figli maschi che curano i genitori siano in crescita è sicuramente vero. Quando ci sono però figlie femmine in famiglia, accade ancora troppo frequentemente che siano loro ad assumersi il carico maggiore, se non totale della gestione della cura. La ribellione a questo delle figlie stesse è ancora spesso troppo silenziosa: non di rado si osservano più inclini a giustificare l’assenza dei loro fratelli che a pretendere in modo più autorevole la loro presenza. Bisogna tenere a mente in modo costante che i genitori sono di entrambi e che il lavoro di cura non è di sola pertinenza femminile.
Legittimarsi a dire ‘no’
Che limitare la propria presenza di fronte a un genitore che si ama e che si vede soffrire, sia estremamente difficile e doloroso, è un fatto incontestabile. Occorre però imparare a essere affettuosi, ma anche fermi con i propri genitori, quando si sono trovate soluzioni alternative per l’espletamento di alcun compiti. Anche quando il genitore fa resistenza. Consapevoli che acquisire un’autorevolezza nei confronti di un genitore su questioni che lo riguardano, è per un figlio una fra le cose più difficili e dolorose, per niente naturale e acquisita. Proprio perché deve accettare sia il dolore sia il turbamento di imparare a ricoprire in parte la funzione di sostegno e di guida autorevole, che il genitore è sempre stato per lui.
Ci sono anche altri affetti e doveri
Un figlio e una figlia devono sempre ripetersi che insieme al dolore, al desiderio di alleviare le sofferenze dei propri genitori, ci sono anche altre responsabilità e affetti della loro vita che vanno ugualmente tutelati, oltre a se stessi: famiglia, partner, figli, amici che siano. Non solo. Un figlio e, nella fattispecie, una figlia, deve anche tutelare proprio quello che una madre avrebbe desiderato per lei, se fosse stata in una condizione non di malattia e di sofferenza come quella attuale. Una condizione che, per forza di cose, la priva delle forze fisiche e mentali necessarie a comprenderla nei suoi legittimi bisogni di conservare anche spazi personali.
Una figlia deve tenere a mente in modo costante che nessuna madre, a meno di situazioni patologiche, desidererebbe che la vita della propria figlia andasse a rotoli mentre la cura. Quando si riesce almeno un po’ a marciare in queste direzioni, la lunga cura della propria madre può aprire allora anche a occasioni affettive particolarmente significative, a momenti di incontro e di scambio emotivo preziosi, speciali e intensi. Unici proprio perché vissuti in una dolorosa consapevolezza di un tempo non più infinito, oggi però più lungo, prima di doversi salutare. Non sono poche le figlie che allora, con enorme commozione e gratitudine, raccontano anche di questo, come di una nuova e straordinaria opportunità.
Articolo di Silvia Lo Vetere – pubblicato su La27esima ora del Corriere.it
Fonte: https://minotauro.it/madri-delle-nostre-madri-perche-ci-sentiamo-colpa/