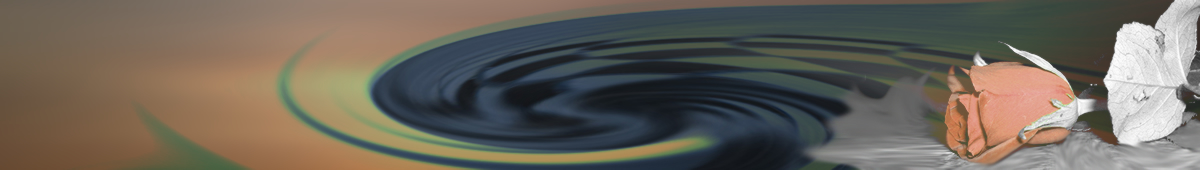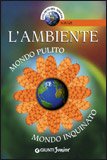di Julia Blunck
Gli incendi che stanno devastando l’Amazzonia in questi giorni sono solamente l’ultimo tassello di una devastazione che parte da lontano, affondando le sue radici nell’economia coloniale e neo-coloniale.

L’attuale Presidente Jair Bolsonaro, sta portando all’estremo questa devastazione, avendola inserita nel suo programma strategico che prevede, al contempo, la guerra alle popolazioni indigene e il rilancio dell’agro-industria. È palese, infatti, che gli incendi di questi giorni rispondano a queste esigenze; altrettanto palese è che la squallida ironia con cui il Presidente brasiliano li ha affrontati nel discorso pubblico, sia espressione del più becero negazionismo climatico e ambientale che già lo ha abbondantemente contraddistinto nei mesi passati.
In questo articolo, tratto dal blog Sottolequerce, la giornalista e scrittrice brasiliana Julia Blunck parla del devastante sfruttamento del “polmone del mondo” tra passato e presente. A pochi giorni dal “Venice Climate Camp”, appare chiaro come la sfida climatica si arricchisca di nuovi elementi di discussione e conflitto.
Dorothy Stang aveva 73 anni quando è stata uccisa. Si è trovata faccia a faccia con il suo assassino, gli ha detto di non essere armata, ha tirato fuori la sua Bibbia e ha letto un paio di versetti. Il sicario è rimasto impassibile, ha sparato sei colpi e l’ha lasciata morire. L’omicidio è stato commesso ad Anapu, una piccola città dello stato del Pará, in Brasile. Stang era una missionaria cattolica della Commissione pastorale della terra e lavorava insieme ai braccianti e ai piccoli proprietari agricoli per uno sviluppo sostenibile delle loro terre. Si batteva per difendere l’Amazzonia, non solo in quanto paradiso terrestre pieno di alberi e animali esotici: sapeva che la foresta era la chiave della sopravvivenza per molte delle popolazioni più povere del paese.
Questo la rendeva pericolosa agli occhi degli agricoltori più ricchi. La suora non si limitava a difendere un concetto vago di natura: considerava l’Amazzonia l’unica risorsa per le persone che altrimenti non avrebbero avuto niente. Con la sua presenza la Stang disturbava tutti i potenti gruppi che volevano sfruttare la foresta per ricavarci un profitto e presto aveva cominciato a ricevere minacce di morte. Pochi giorni prima di essere uccisa, si era rivolta alle autorità incaricate di proteggere i diritti umani, nella speranza che il governo facesse qualcosa. Nessuno si è mosso.

È facile pensare che questa brutta storia si svolga nel presente, nel Brasile di Jair Bolsonaro. Il presidente di estrema destra ha costruito il suo successo negando l’emergenza climatica, annunciando la fine delle tutele ambientali e chiamando “terroristi” gli attivisti per l’ambiente. Dal giorno del suo insediamento, il 1 gennaio 2019, Bolsonaro proibisce agli enti ambientali di parlare con la stampa e sta accarezzando progetti di sfruttamento minerario che avrebbero un impatto disastroso sull’Amazzonia. Chi si batte per proteggere la foresta è indicato non solo come nemico del presidente, ma anche come nemico della nazione. Il Brasile che Bolsonaro vuole costruire, è un paese dove il potere di chi commercia il legname e quello degli allevatori conta più di tutto, mentre la vastità della foresta e la sua gente non avranno nessun valore.
Dorothy Stang, però, non è stata uccisa durante il governo di Bolsonaro, ma nel 2005. Alla presidenza c’era Luiz Inácio Lula da Silva (del Partito dei lavoratori, sinistra), che per molti osservatori ha guidato il governo più progressista della storia del Brasile. Erano gli anni d’oro del paese, quando l’Economist cantava le sue lodi, si organizzavano vertici con Tony Blair per costruire insieme la terza via. Erano gli anni in cui il Brasile veniva scelto per ospitare i Mondiali e le olimpiadi. La povertà diminuiva e l’economia era in buona salute. Dall’esterno, Lula dava l’impressione di prendere sul serio le questioni ambientali: sostenne gli accordi di Kyoto, disse di comprendere il pericolo del riscaldamento globale e rallentò il ritmo della deforestazione dell’Amazzonia. Ma perfino in quegli anni, i migliori del Brasile, parti della foresta furono ridotte in cenere e la questione amazzonica fu annegata nel sangue.
Punto di arrivo
L’Amazzonia occupa un posto strano nella mente dei brasiliani. Gran parte di loro è orgogliosa della vastità di questa foresta pluviale e della sua biodiversità. Eppure, in un paese dove non tutti hanno accesso ai servizi igienici e sanitari di base, la questione ambientale spesso passa in secondo piano e lascia il posto ad altre più urgenti. L’ambiente è al quarto posto nei sondaggi sulle preoccupazioni principali dei brasiliani, dopo violenza, corruzione e salute, temi che spesso condizionano il risultato delle elezioni.
Eppure gran parte della foresta amazzonica si estende dentro i confini del Brasile. Se l’Amazzonia brasiliana fosse uno stato, sarebbe il settimo più grande del mondo, più vasto dell’India. Ma è anche vero che alcune zone della foresta sono completamente isolate e può capitare che vengano scoperte nuove specie. Solo il 12 per cento della popolazione brasiliana vive nella regione e la maggior parte non la visita mai.
Quindi per i brasiliani l’Amazzonia è una specie di grande astrazione. Distante dalla maggioranza dei cittadini, somiglia a una terra straniera intravista in qualche documentario o sui libri di scuola. A ogni brasiliano capita di meravigliarsi pensando ai suoi grandi fiumi, ai petali della Victoria amazonica e agli uccelli colorati, ma queste cose si dimenticano in fretta: la conservazione della foresta può anche essere considerata importante, ma tutti pensano che sia responsabilità di qualcun altro.

La maggioranza dei brasiliani non ha votato esplicitamente per la distruzione dell’Amazzonia. È orribile immaginare la foresta in fiamme, l’immensa distesa di alberi interrotta da buchi grandi come stadi di calcio o gli animali che soffocano per il fumo nero che oscura il cielo. Ma votare per la distruzione dell’Amazzonia è proprio quello che il Brasile ha fatto per decenni: uno dei gruppi politici più forti del parlamento è la cosiddetta bancada ruralista, che rappresenta i grandi monopoli agricoli. Il suoi deputati bocciano ogni proposta di legge che vuole salvaguardare l’ambiente e i diritti degli indigeni.
Per l’industria agricola, l’Amazzonia è una terra non sfruttata che può lasciare posto ai pascoli e alle piantagioni. Ci sono molti soldi in gioco: il paese è il primo produttore al mondo di soia e ogni anno esporta nel mondo 1,6 milioni di tonnellate di carne bovina per un valore di 6,5 miliardi di dollari. La maggior parte della terra occupata dalle coltivazioni di soia e dagli allevamenti è in Amazzonia: negli ultimi vent’anni il numero di bovini qui è passato da 37 a 85 milioni di capi.
Per liberare i terreni non si abbattono solo i grandi alberi essenziali all’ecosistema. Si dà fuoco alla vegetazione e a tutto quello che custodisce, impoverendo il suolo. Questa pratica non solo accelera il processo di desertificazione, ma riduce anche il tempo di vita di un terreno. E a sua volta provoca nuovi incendi e costringe i contadini a spostarsi in cerca di terreni più fertili.
La sinistra ha le sue responsabilità. Il Partito dei lavoratori – quello di Lula prima e di Dilma Rousseff poi – ha stretto varie alleanze con la lobby dei grandi proprietari terrieri e ha appoggiato progetti per sfruttare la regione, nonostante l’opposizione degli ambientalisti e delle organizzazioni che difendono i diritti delle popolazioni indigene. Un esempio è la diga di Belo Monte costruita sul fiume Xingu, nello stato del Pará. La diga, la quarta più grande del mondo, ha privato le comunità indigene locali del loro sostentamento: per farla sono stati abbattuti 175 chilometri quadrati di foresta protetta e ne sono stati allagati cinquecento. L’opera, che era stata progettata durante la dittatura (1964-1985), non è stata realizzata dalla destra, ma da Lula. Per quanto violento sia oggi l’atteggiamento di Bolsonaro contro l’ambiente, quindi, non è nuovo per il Brasile. Né lui né la sua indifferenza brutale verso l’Amazzonia sono forze estranee alla politica del paese. In un certo senso, sono il loro punto di arrivo.
Autostrada del fallimento
L’Amazzonia brasiliana era considerata una risorsa economica durante il boom della gomma alla fine dell’ottocento e ai primi del novecento, ma rimase per lo più intatta fino agli anni sessanta. La situazione cambiò con la dittatura militare. Oggi Bolsonaro raccoglie quell’eredità. Secondo i generali brasiliani, quella amazzonica era una regione arretrata da sfruttare. I cosiddetti progetti faraonici della dittatura erano, ai loro occhi, un’opportunità per trascinare queste aree isolate del nord verso il futuro.

Uno di questi progetti era un’immensa autostrada, la Transamazônica, inaugurata negli anni settanta. Quest’autostrada incarna la proverbiale inaffidabilità del Brasile quando è alle prese con grandi opere d’infrastruttura: troppo ambiziosa, inutilmente costosa e mai completamente finita. La Transamazônica era stata pensata per essere molto più di una strada. Il governo sperava di far alloggiare un milione di persone in una serie di villaggi e città da costruire lungo il percorso. Ogni dieci chilometri sarebbe nato un villaggio con un numero di case variabili da 48 a 64, una scuola e un ambulatorio. I villaggi sarebbero stati sotto il controllo di piccoli centri abitati, uno ogni cinquanta chilometri. A loro volta, in questi centri ci sarebbero state cinquecento case, negozi e distributori di benzina. Tutti sarebbero dipesi amministrativamente da città più grandi, una ogni 150 chilometri. I nuovi alloggi erano destinati ai brasiliani provenienti dalle zone del nordest dove c’era la siccità. Furono costruiti solo venti insediamenti e appena ventimila famiglie ebbero una casa. Al loro arrivo non trovarono molta assistenza, ma fame, malattie e un terreno difficile.
Neanche l’autostrada fu un successo. Partendo dalla città di Cabedelo, nel nordest del paese, avrebbe dovuto tagliare l’Amazzonia e raggiungere il confine con il Perù, procedendo a zig-zag per ottomila chilometri. Alla fine il progetto fu abbandonato, lasciando completati solo 4.200 chilometri. Oggi per lunghi tratti la strada non è asfaltata e nei mesi delle piogge non è percorribile. Questo colossale monumento al fallimento costò al regime un miliardo e mezzo di dollari. Possiamo solo immaginare le transazioni illecite che ci furono intorno al progetto.
Il danno ambientale, tuttavia, era stato fatto. Se dobbiamo indicare il momento preciso in cui né la distanza né la vastità avrebbero più potuto proteggere l’Amazzonia dalla distruzione umana, la costruzione della Transamazônica è un buon punto di partenza. Una volta aperta la strada ai camion, la deforestazione accelerò, poi arrivarono i disboscatori e gli allevatori. La foresta era diventata vulnerabile. Si calcola che negli anni ottanta, dieci anni dopo che l’autostrada aveva aperto un primo passaggio attraverso la foresta, fu abbattuta un’area di 56mila chilometri quadrati.
La perdita di alberi secolari e di specie ancora sconosciute provocò grande indignazione, ma fu il massacro delle comunità indigene il vero orrore nascosto dietro alla costruzione della Transamazônica. Per permettere il passaggio della strada intere comunità furono allontanate, anche con la forza. La dittatura brasiliana viene spesso considerata “morbida” se paragonata a quelle dei paesi vicini, Cile e Argentina. Le persone “scomparse” furono centinaia, non migliaia. Ma queste stime non tengono conto di quello che fu fatto alle popolazioni indigene: migliaia di nativi morirono a causa di malattie portate dai nuovi occupanti. Ci furono le violenze sessuali, la tortura, il trasferimento forzato e gli omicidi.
Dimenticare

L’eredità della dittatura non è mai stata davvero ripudiata e il Brasile ha fatto come sempre: ha dimenticato e ha evitato il confronto con la sua storia. L’idea che l’Amazzonia sia una regione arretrata da riscattare con qualche grande progetto fa ancora parte del pensiero collettivo dei brasiliani. Durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2018, perfino a sinistra qualcuno affermava che la dittatura, pur avendo le sue colpe, almeno aveva investito nel paese. E oggi Bolsonaro elogia il passato regime militare.
Gli anni ottanta furono un periodo di transizione per il Brasile, la democrazia era appena nata, segnata dalla morte precoce di quello che avrebbe dovuto essere il suo primo presidente democratico, Tancredo Neves, e dalle politiche economiche aggressive del suo successore, José Sarney. Sarney veniva da una dinastia di proprietari terrieri e non aveva motivi per interessarsi allo stato della foresta amazzonica. Ma nel 1988 non poté ignorare il primo gravissimo omicidio nell’Amazzonia: quello del sindacalista Chico Mendes, un attivista che aveva rivelato al mondo i danni provocati dai grandi agricoltori e allevatori.
Mendes era la figura di spicco del movimento per la tutela dei lavoratori della gomma nella regione amazzonica. Estrarre la gomma è considerato un modo molto più sostenibile di usare le risorse amazzoniche rispetto all’allevamento e al commercio di legname, perché lo stesso albero può essere usato per più di dieci anni. Ci sono molti paralleli tra l’omicidio di Mendes e quello di Stang. Anche Mendes aveva subìto le minacce degli agricoltori per anni e fu ucciso dal figlio di un ricco proprietario terriero. L’omicidio portò la questione amazzonica nel dibattito pubblico brasiliano. I governi successivi estesero le aree protette e nel 2007 è stato creato l’istituto Chico Mendes per la tutela della biodiversità (Icmbio) sotto l’egida del ministero dell’ambiente.
Anche se la morte del sindacalista ha favorito l’emergere di alcuni politici ecologisti, come Marina Silva, non ha ridimensionato l’influenza dei grandi agricoltori in parlamento. Tutti i governi, anche quelli guidati da leader più consapevoli, hanno preferito fare concessioni all’agrobusiness invece di sfidarlo.
L’ascesa al potere di Bolsonaro è spesso descritta come la traiettoria di un ribelle. Si parla di come ha cavalcato l’onda del malcontento, della sua difesa dei “valori cristiani”, della sua oratoria incisiva (o trumpiana, secondo alcuni), della sua “brutale onestà” nello sfidare la classe dirigente. Ma al netto della retorica contro lo status quo, Bolsonaro ha avuto il sostegno fondamentale di tre gruppi del parlamento: gli evangelici, la lobby delle armi e, ovviamente, l’industria agricola.

La minaccia del presidente al polmone verde del pianeta non è velata: “Il paese non può avanzare”, ha detto, “se intere parti del suo territorio sono usurpate dalle riserve, dai parchi nazionali e dalle aree protette”. Bolsonaro governa da qualche mese e la lobby degli agricoltori è soddisfatta. La deforestazione era già aumentata durante la campagna elettorale del 2018, con un incremento del 13,7 per cento rispetto all’anno precedente; la moratoria sulla soia, che per più di dieci anni ha impedito la vendita del legume coltivato in aree disboscate, difficilmente sarà rinnovata e le richieste della bancada ruralista per ottenere più terra da pascolo saranno soddisfatte.
Bolsonaro ha perfino cercato di eliminare il ministero dell’ambiente, una mossa che ha messo in allarme molti fuori dal Brasile e che è stata giudicata eccessiva anche dall’industria agricola: nessuno vuole giocare in maniera così scoperta. Il presidente ha mantenuto il ministero, ma ne ha limitato i poteri, e ha annunciato di voler abolire le leggi che consentono al governo di multare chi commette crimini ambientali. Secondo lui, il riscaldamento globale è un complotto delle sinistre del mondo per privare il Brasile dei suoi poteri, sottomettendolo a una sorta di burocrazia socialista transnazionale.
Corsa contro il tempo
Quindi la marcia sulla foresta va avanti. È preoccupante, non solo per la perdita di fauna e di vegetazione – molte piante sono usate nella preparazione di medicinali – ma anche per la potenziale perdita di vite umane di cui dovremo rispondere se Bolsonaro continuerà a modellare il suo atteggiamento verso gli indigeni e gli attivisti per l’ambiente su quello della dittatura. Bolsonaro ripete spesso che vuole “integrare” le comunità indigene, affermando che vogliono avere gli stessi benefici di tutti gli altri.
È preoccupante anche per l’impatto sull’ecologia del pianeta: gli alberi della foresta assorbono due miliardi di tonnellate di anidride carbonica all’anno, il 6 per cento delle emissioni globali; producono il 20 per cento dell’ossigeno mondiale. Bastano questi numeri a dimostrare che non può esserci un lieto fine per la storia del riscaldamento globale se non si protegge l’Amazzonia. E la sua distruzione rischia d’innescare una serie di cambiamenti climatici a catena che l’umanità non saprà controllare.
Un rapporto recente del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico ha avvertito che il mondo ha solo dodici anni – ora undici – per evitare una catastrofe climatica. Ma le stime non tengono conto di cosa succederebbe se l’Amazzonia fosse distrutta da Bolsonaro in nome del progresso. Se davvero l’esistenza umana sul pianeta è impegnata in una corsa contro il tempo, allora il nuovo governo brasiliano ci sta rubando minuti di vita. In passato il mondo poteva permettersi di pensare all’Amazzonia come a un problema solo brasiliano. Oggi, per la prima volta dall’inizio della devastazione sanguinosa della foresta, a pagare le conseguenze non sarà solo il Brasile, ma il mondo intero.
Articolo di Julia Blunck
Fonte: https://www.globalproject.info/it/mondi/la-devastazione-dellamazzonia-tra-passato-e-presente/22205