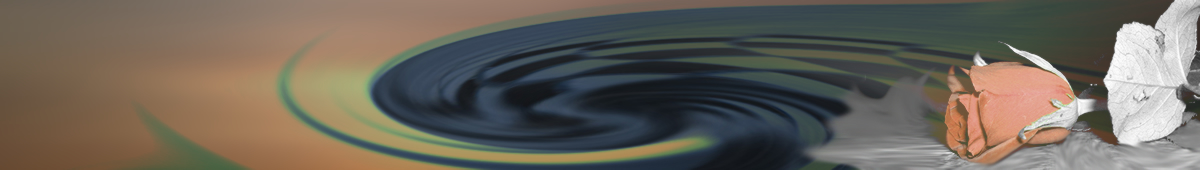di Silvia Granziero
La Groenlandia sarà sempre di più un punto nevralgico nei commerci mondiali tra Europa e Asia, lungo le rotte del Polo Nord. Ancora una volta, l’avidità di un ristretto gruppo di persone – investitori, mossi solo dalle possibilità di guadagno a breve termine – sta condannando il futuro di tutto il Pianeta e dei suoi sette miliardi di abitanti.

Il 2019 è stato il secondo anno più caldo mai registrato nella storia. Più ci si avvicina ai Poli e più gli effetti sono drammatici: al Circolo Polare Artico, il livello di surriscaldamento può essere anche doppio rispetto alle nostre latitudini, perché senza neve solo il 5% dell’energia solare viene riflessa, contro il normale 85-95%.
Le immagini satellitari della Groenlandia raccolte tra il 1992 e il 2018, hanno evidenziato un ritmo di scioglimento dei ghiacci nella regione di molto superiore alle previsioni. Nella finestra temporale considerata, la Groenlandia ha perso circa 3.800 miliardi di tonnellate di ghiacciai – riporta uno studio pubblicato su Nature – con un conseguente innalzamento globale del livello dei mari di circa 10 millimetri.
Entro il 2100 le acque potrebbero ancora salire tra i 50 e i 120 millimetri: per tante specie animali questo significa la scomparsa del loro habitat e la condanna a morte per fame, mentre per il Pianeta un clima imprevedibile. Per 400 milioni di persone ogni anno il rischio di essere vittime di alluvioni e allagamenti diventerà sempre più concreto. Ma davanti a questo scenario molti preferiscono pensare ai vantaggi e ai guadagni nello sfruttare la regione Artica, dove si trova il 40% delle risorse globali di idrocarburi rimaste.
La Groenlandia – fino ad ora dipendente dai fondi provenienti dalla Danimarca, da cui è solo parzialmente autonoma – è oggi, per armatori e compagnie di estrazione, il nuovo “Eldorado”. Il disgelo in questa terra inospitale, consente un più facile accesso a terre rare e giacimenti di gas. La Groenlandia sarà sempre di più un punto nevralgico nei commerci mondiali tra Europa e Asia, lungo le rotte del Polo Nord.
Quella che è stata battezzata Northern sea route è un’alternativa sempre più allettante al passaggio per il Canale di Suez: fino al 30-40% più corta di quest’ultimo – dove ogni anno transitano 18mila imbarcazioni – dura solo una decina di giorni. Se il ritmo di scioglimento dei ghiacci continuerà come ora, a breve, sentiremo anche parlare della rotta transpolare, di ben due terzi più breve rispetto a quella di Suez.

La Russia, grazie alla sua posizione, è già pronta ad approfittarne: fornirà le infrastrutture e le navi rompighiaccio con la prospettiva di imporre tariffe per il passaggio. Nel 2014 l’ambasciatore russo per gli affari artici Anton Vasiliev, al convegno Arctic Frontiers – che riunisce politici, ricercatori, società civile e rappresentanti delle popolazioni indigene del Nord – ha promesso la costruzione di tre navi rompighiaccio a propulsione atomica e cinque a diesel, oltre a dieci centri di ricerca e soccorso e alla ristrutturazione di altrettanti porti che si affacciano sull’Oceano Artico.
Anche gli altri Paesi che vi si affacciano vogliono la loro parte di profitto, approfittando della Convenzione Onu sul diritto del mare. Secondo la carta, gli Stati costieri possono rivendicare porzioni di crosta continentale sommersa secondo criteri scientifici. La Norvegia ha così ottenuto vasti territori nel mare di Barents, nel mar di Norvegia e nel bacino occidentale di Nansen, concedendo varie licenze di esplorazione, anche all’Eni. Nel frattempo, i cavi sottomarini per la fibra ottica vengono tirati dalla Finlandia al Giappone, per connettere anche l’estremo nord alla rete globale.
Se la Northern sea route riduce il consumo di energia per il trasporto, provoca però un aumento dell’inquinamento nel fragile ecosistema artico, contribuendo a sua volta ad accelerare lo scioglimento dei ghiacci, senza contare il rischio di perdite di carburante e il problema dello smaltimento delle scorie. Nonostante le preoccupazioni delle popolazioni indigene coinvolte, tra cui gli Inuit della Groenlandia e i Sami della Lapponia, sono in troppi a concordare con l’opinione dell’ex premier groenlandese Aleqa Hammond, che riconosce come “In Groenlandia i vantaggi dell’effetto serra sono maggiori degli svantaggi”. Tradotto, meglio guadagnare ora che preoccuparsi dei disastri ambientali – e, quindi, sociali, economici e sanitari – di domani.

Nel caso della Groenlandia, lo sfruttamento delle risorse può essere la chiave economica per permettersi l’indipendenza dalla Danimarca. Una ghiotta prospettiva di arricchimento per un Paese funestato da disoccupazione, alcolismo, violenza domestica e suicidi giovanili. Aqqaluk Lynge, tra i fondatori del partito Ataqatigiit al governo fino al 2013, ha riassunto: “Se vuoi diventare ricco devi pagare un prezzo”. E se al suo partito questa opzione non piaceva, le cose sono cambiate nel 2013 con il nuovo governo del partito Siumut, che ha revocato i precedenti divieti di attività mineraria sull’isola. “La decisione che abbiamo preso […] avrà enormi conseguenze sullo stile di vita e la cultura indigena. Ma alla fine supereremo tutto. Siamo vulnerabili, ma sappiamo adattarci”, sono state le parole di Hammond. In questo modo la Groenlandia si è aperta alle speculazioni di investitori stranieri, compagnie asiatiche e multinazionali: nel sud del Paese, a Kvanefjeld, esiste già una miniera di terre rare e uranio gestita da un consorzio sino-australiano, mentre altri progetti da miliardi di dollari sono in fase di discussione e costruzione.
Anche il settore agricolo rischia di essere stravolto dal surriscaldamento globale, e a guadagnarci saranno le nazioni più fredde (Russia e Canada in primis, oltre alla Scandinavia), dove l’aumento delle temperature e il prolungamento della stagione di crescita garantiscono raccolti più ricchi e la sopravvivenza di specie animali un tempo inadatte ai climi più rigidi.
In Canada, per esempio, sempre più coltivatori piantano granturco: se oggi la “fascia del mais” è negli Stati Uniti, tra Iowa, Illinois e Indiana, in 50 anni potrebbe spostarsi nella Baia di Hudson, in Canada, che nel frattempo investe sulla coltivazione della soia. Cambia anche la geografia del vino: mentre in Italia, Spagna e Francia meridionale i raccolti sono già minacciati da siccità prolungate ed eventi atmosferici estremi – e secondo uno studio le aree vitivinicole più note entro il 2050 potrebbero ridurre le aree di produzione tra il 20 e il 70% – nell’Europa centro-settentrionale si iniziano a piantare vigneti dove fino a qualche anno fa sarebbe stato impossibile.

Se l’irregolarità del meteo deve preoccupare tutti, per il momento del climate change beneficiano i viticoltori tedeschi, sulle cui terre il clima garantisce la crescita di uve gustose e zuccherine. Il periodo della vendemmia cade sempre prima e qualcuno ha già provato a piantare uve Riesling in Norvegia. E le raccoglie mature, tanto che l’ipotesi di una bottiglia di vino scandinavo non è più fantascienza. Da noi, invece, presto le estati saranno troppo secche perché l’uva cresca senza irrigazione artificiale, rendendola in molti casi insostenibile sui piani economico e ambientale. Ovviamente gli eventi atmosferici estremi possono vanificare da un momento all’altro i vantaggi ottenuti, ma ancora una volta vince la filosofia di approfittare dei guadagni a breve termine piuttosto che preoccuparsi delle prospettive future.
Nemmeno il terziario si lascia scappare l’occasione fornita dal climate change a un’altra delle grande industrie del XXI secolo: il turismo. È in espansione il last chance tourism, l’ultima occasione di visitare luoghi incontaminati, una delle ghiotte opportunità derivate dallo scioglimento dei ghiacci artici. L’Islanda è da qualche anno presa d’assalto da un turismo spinto dal fenomeno Game of Thrones, con gruppi di sprovveduti che chiedono a che ora viene accesa l’aurora boreale, come racconta lo scrittore Hallgrímur Helgason.
Ma se il boom del turismo islandese mostra già segni di declino e il Paese si preoccupa di come sostituire la fonte di reddito che l’ha aiutato a risollevarsi dalla bancarotta, i tour operato guardano a nord. Le navi da crociera progettate per l’Egeo, il Mediterraneo o i mari tropicali si avventurano lungo le coste della Groenlandia e delle isole Svalbard. Questa ricerca delle emozioni forti per compiacere i turisti, arrivando a sfiorare gli iceberg, aumenta però il rischio di incidenti gravi, in un’area dove i soccorsi possono impiegare anche tre ore a raggiungere una nave in avaria, sempre che le comunicazioni funzionino.
Chi ha solo da perdere per l’emergenza climatica sono come sempre i più poveri. Il climate change infatti allarga il gap tra gli Stati ricchi e in via di sviluppo del mondo, che è maggiore del 25% di quanto sarebbe senza il surriscaldamento globale. La fascia tropicale africana e la più colpita, con un Pil pro capite fino al 40% più basso di come sarebbe stato senza l’aumento delle temperature. Tra il 1961 e il 2010, tutti i Paesi responsabili di meno di 10 tonnellate di anidride carbonica pro capite di emissioni storiche globali, hanno sofferto gli effetti del cambiamento climatico con una riduzione del Pil pro capite del 27%. Negli stessi anni, quattro dei 19 Paesi colpevoli di oltre 300 tonnellate di anidride pro capite hanno conosciuto un aumento del Pil pro capite del 13%.
Sul lungo periodo il climate change non può che danneggiare tutti, ma le sue disastrose conseguenze per ora non sembrano preoccupare gli investitori, mossi solo dalle possibilità di guadagno a breve termine. Ancora una volta, l’avidità di un ristretto gruppo di persone, sta condannando il futuro di tutto il Pianeta e dei suoi sette miliardi di abitanti.
Articolo di Silvia Granziero
Fonte: https://thevision.com/habitat/capitalismo-cambiamento-climatico/?sez=author&ix=2&authid=208