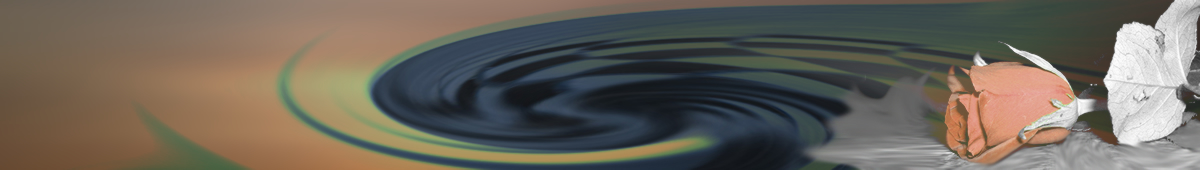di Sebastiano Caputo
L’industria culturale nella società dell’intrattenimento denigra la genialità e produce solo talenti profondamente conformisti, effimeri, consumabili, “usa e getta”. La letteratura suggerisce il libro dell’anno, il cinema premia i film più avvincenti, l’arte concepisce “ready made” e “happening”, la musica si riduce al “Talent Show”.
 Come in politica, anche nel mondo artistico si distinguono genio e talento. Otto Weininger (filosofo austriaco), morto suicida all’età di ventitré anni per colpa di una scommessa persa con un amico, scriveva a proposito: “il genio è l’uomo atemporale e le sue opere vivono eternamente”. Il genio è inattuale perché sfugge al presente, non è figlio della sua epoca, tanto meno può essere spiegato in relazione ad essa.
Come in politica, anche nel mondo artistico si distinguono genio e talento. Otto Weininger (filosofo austriaco), morto suicida all’età di ventitré anni per colpa di una scommessa persa con un amico, scriveva a proposito: “il genio è l’uomo atemporale e le sue opere vivono eternamente”. Il genio è inattuale perché sfugge al presente, non è figlio della sua epoca, tanto meno può essere spiegato in relazione ad essa.
Questa è la ragione per cui l’industria culturale nella società dell’intrattenimento denigra la genialità e produce solo talenti profondamente conformisti, effimeri, consumabili, usa e getta. La letteratura suggerisce “il libro dell’anno”, il cinema premia i film più avvincenti, l’arte concepisce “ready made” e “happening”, la musica si riduce al “Talent Show”.
In fondo, il genio musicale ripudia la televisione, non passa in radio, se ne frega di vendere dischi, vede il mainstream come un tradimento. È la storia di Rino Gaetano, legato alla sua terra di origine, la Calabria, ostile nei confronti delle etichette discografiche, scettico in merito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, ma costretto dalla RCA (casa discografica) a cantare “Gianna” invece di “Nuntereggae più”, come invece avrebbe voluto lui. Quella musica che lui stesso detestava – dopo il festival, pentito, disse: “Sanremo non significa niente e, non a caso, ho partecipato con Gianna che non significa niente” – ebbe però un grande successo, rimanendo per quattordici settimane nella Top Ten e vendendo oltre 600 mila copie. “Gianna”, commerciale, melodica, priva di senso, faceva del genio Gaetano, un semplice cantante di talento, un esecutore, un personaggio d’intrattenimento.

Fabrizio De Andrè
Allo stesso modo, Fabrizio De André affermava, nel 1984, ai microfoni di Mixer: “certe volte mi sentivo inorgoglito, altre volte deluso. Ma sempre in ogni caso un po’ vergognoso a vedermi quasi costretto a sfogliare le riviste specializzate, per scrutare con un occhio quasi da lumaca, fuori dalle orbite, quale posizione avesse ottenuto in classifica il mio ultimo, cosiddetto, prodotto discografico. Perché questo voleva dire che il disco in quanto funzione oggettiva di consumo, aveva assunto un’importanza superiore a quella delle canzoni per le quali viveva, e nelle quali sinceramente mi sentivo di avere vissuto”.
 I tempi sono cambiati, gli artisti anche. Ad Alessandro Mannarino, unico ed ultimo erede della cultura musicale degli anni Settanta, si contrappongono i concorrenti di X Factor, i quali, a furia di professarsi trasgressivi, tra tatuaggi, bling bling, spogliarelli, piercing, smanicati, vestiti alla moda, capelli platinati, non fanno altro sacrificarsi sull’altare dell’omologazione.
I tempi sono cambiati, gli artisti anche. Ad Alessandro Mannarino, unico ed ultimo erede della cultura musicale degli anni Settanta, si contrappongono i concorrenti di X Factor, i quali, a furia di professarsi trasgressivi, tra tatuaggi, bling bling, spogliarelli, piercing, smanicati, vestiti alla moda, capelli platinati, non fanno altro sacrificarsi sull’altare dell’omologazione.
Questa assolutizzazione dell’arte musicale, che di fatto è sinonimo di appiattimento culturale, viene santificata da quattro giudici che non cercano il genio, ma il talento, che non vogliono l’avanguardia ma l’imitazione. Mai come nei Talent Show il critico d’arte si è trasformato nel portavoce dell’industria culturale, che inserisce e lancia nuovi prodotti nel mercato discografico.
Articolo di Sebastiano Caputo (titolo originale: “Geni che odiano i talenti”)
Fonte: http://www.lintellettualedissidente.it/editoriale/geni-che-odiano-i-talenti/