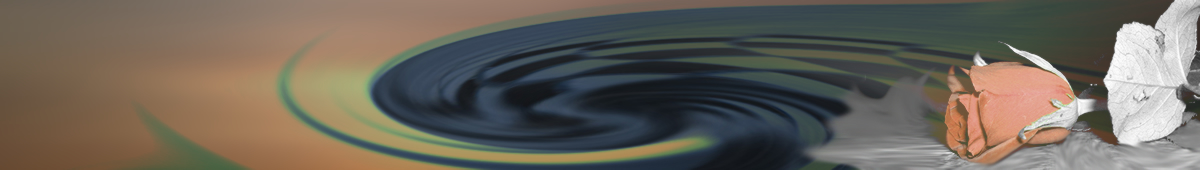L’immigrazione di massa integra chiaramente un caso di guerra tra poveri. Non solo perché lo è nei fatti – con milioni di persone a contendersi alloggi insufficienti, lavori sottopagati o di bassa manovalanza criminale, periferie anguste e i palliativi di un welfare centellinato dai tagli – ma anche perché così si vuole che sia, o quantomeno ce la si mette tutta affinché lo diventi.

Qualche anno fa, nei giorni in cui il Comune di Milano decideva di trasferire 400 euro al mese a chi accogliesse un profugo nella propria abitazione, nella stessa città moriva di stenti Giovanni Ceriani, un disabile di cittadinanza italiana che si manteneva con un assegno di 186 euro al mese e un bonus comunale di 1.000 euro all’anno. Non c’è bisogno di essere leghisti per capire che finirà male, malissimo, anche perché di casi simili se ne contano a bizzeffe.
In un sistema di finanza pubblica dove la scarsità di investimenti è postulata come un dogma, è inevitabile che i poveri e gli impoveriti si contendano le briciole e temano l’arrivo di nuove bocche da sfamare. Tanto più se quello stesso sistema predica anche la scarsità dei salari e delle tutele come una virtù e la scarsità di lavoro come una colpa, non lasciando ai deboli altra scelta che un cannibalismo di sopravvivenza in cui l’odio etnico e razziale è solo il pretesto di una guerra per bande.
C’è del dolo o comunque una sterminata irresponsabilità in chi sostiene queste politiche di scarsità e al tempo stesso auspica corridoi umanitari per prelevare gli stranieri alla fonte, chiede la rimozione dei blocchi alle frontiere e sogna di accogliere 300-400 mila persone ogni anno, se non 30 milioni in 15 anni. Salvo poi, al delinearsi di una catastrofe umanitaria che colpirebbe tutti – in primis gli immigrati di cui si fanno paladini – sfoderare il ferro vecchio della rivoluzione culturale e rimproverare ai sudditi il vizio della xenofobia, lanciando vibranti campagne contro l’odio. Quasi fossero, la xenofobia e l’odio, patologie dalle origini oscure da debellare con la profilassi (nei giovani) e gli antibiotici (nei vecchi) e non un’etologica conseguenza delle politiche da loro stessi create.
C’è del dolo e dell’irresponsabilità in questa filantropia a spese degli altri, ma c’è anche e soprattutto il suo contrario, cioè del razzismo. Che non è il razzismo di cui si lamentano i progressisti: l’islamofobia e il disprezzo di civiltà diverse che è già condannato a reti unite e neanche l’ “autorazzismo” di cui si parla quando i bisogni degli stranieri sono anteposti a quelli degli autoctoni, ma è il “razzismo dei buoni”, che colpisce invece proprio loro: gli immigrati, che protegge a parole e trasforma nei fatti in strumenti di un piccolo e penoso esercizio di autocertificazione etica e di un più grande disegno socio-economico di sfruttamento degli ultimi.

L’idea che abbiamo bisogno (?) dello sperma di milioni di disperati per ripopolare un continente in stasi demografica, o delle loro braccia per svolgere i lavori che gli italiani non vogliono più fare (cioè quelli sottopagati), non differisce in principio dalle deportazioni degli schiavi africani negli Stati Uniti del sud o dei forzati nelle colonie inglesi da ripopolare.
Allora li si prelevava con la violenza, oggi li si costringe con la violenza del debito, della guerra e dello sfruttamento – che i deportazionisti buoni chiamano rispettivamente aiuti (sic) internazionali, missioni di peacekeeping e investimenti diretti esteri, e li sostengono pulendosi la coscienza con un’agile mossa lessicale. Ritenere normale che alcuni paesi del mondo, i più poveri, siano serbatoi di carne umana da ricollocare, alla bisogna, dei meno poveri soddisfa i requisiti non solo del razzismo, ma anche dello schiavismo tout court, e tradisce un disprezzo ignaro ma totale del diritto di queste popolazioni a vivere in pace e prosperità nelle proprie terre di origine.
In quanto al ritornello de i-lavori-che-gli-italiani-non-vogliono-più-fare, gira da più di 20 anni ed è un classico esempio di come si peggiora un problema vero (l’abbassamento dei salari) con una soluzione falsa (l’immigrazione). Se molti mestieri non garantiscono redditi sufficienti per condurre una vita dignitosa, nonostante siano richiesti dal mercato e in molti casi indispensabili, c’è evidentemente un problema di allocazione dei frutti del lavoro, che dalla base produttiva si spostano verso l’alto, ai dirigenti e ai grandi imprenditori fino a raggiungere lo stretto vertice degli investitori finanziari e dei loro vassalli. E se il lavoro vale sempre di meno, in ciò non aiuta la velleità di competere a frontiere aperte e a cambio fisso, con i paesi che ci hanno preceduto nello sfruttamento in larga scala, condannandoci a una guerra globale tra poveri, dove vince chi compra il lavoro, non chi lo svolge.
Per chi si dice di sinistra, questi concetti dovrebbero essere pane quotidiano, se non fosse che l’oppio del moralismo gli ha fatto credere che gli italiani siano pigri e viziati e “non vogliono sporcarsi le mani”, mentre invece i migranti sarebbero baciati da una gran voglia di fare e di migliorarsi attraverso il lavoro duro, umile e senza pretese. Nel raccontarsi questa fiaba si inanellano almeno tre obbrobri:
1) il disprezzo per i propri connazionali che lottano per preservare i propri diritti e il benessere conquistati con il sangue degli avi, oggi derubricati a “privilegi”;
2) la celebrazione della propria eccezione etica (per la nota Equazione di Scanavacca);
3) in quanto agli stranieri, la certificazione del loro status di “morti di fame” disposti a tutto per un pugno di riso, di selvaggi che tutto sommato possono fare a meno del set completo di tutele e benefici formalmente garantiti a chi è nato nell’emisfero dei ricchi.

Se i primi due punti meritano compassione, trattandosi in ultima analisi di autolesionismo, il terzo suscita rabbia e stupore, per i modi in cui i concetti antichi di colonialismo, paternalismo e sfruttamento sono riusciti a riciclarsi nei panni dei buoni sentimenti. L’unica, amarissima, consolazione è che chi ammette la deportazione del povero a beneficio del ricco – sia pure con la bonomia della dama coloniale che getta caramelle ai “negretti” – deve prepararsi a seguirne la sorte, mettendosi al servizio di chi è ancora più ricco, come sta già accadendo.
Forse un giorno ci si accorgerà che combattere la povertà importando poveri, lo schiavismo importando schiavi e la disoccupazione importando disoccupati, non è una buona idea – da qualsiasi parte politica la si guardi. Quel giorno, italiani e stranieri, ovunque ci troveremo, sapremo chi ringraziare.
Rivisto da Conoscenzealconfine.itFonte: http://ilpedante.org/post/lo-schiavismo-dei-buoni