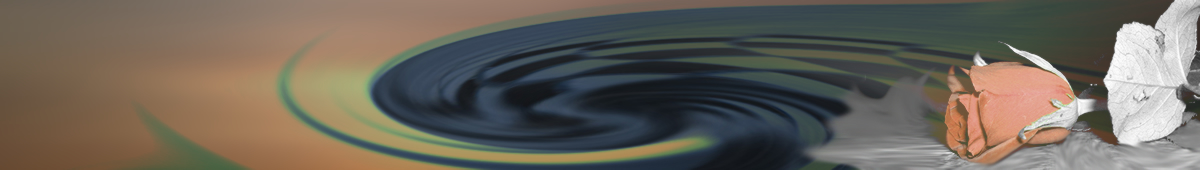di Patrizia Scanu
L’idea di una politica comune europea della scuola e dell’istruzione si fa strada a partire dalla fine degli anni ’80 e coincide con la privatizzazione degli spazi pubblici che è il contrassegno stesso della globalizzazione economica.

Si tratta di un vero e proprio colpo di mano elitario, che mette di fatto l’educazione delle nuove generazioni nelle mani della Commissione europea e dei gruppi di pressione che ne dirigono l’azione e ne orientano l’ideologia.
Fino al Trattato di Maastricht non era prevista una politica europea comune della scuola. A ogni nazione veniva lasciata piena autonomia decisionale nell’ambito dell’istruzione. Ma nel 1989 la Tavola Rotonda Europea degli Industriali (in inglese la sigla è E.R.T.I.), riunitasi per la prima volta a Parigi nel 1983 per iniziativa di Pehr G. Gyllenhammar, l’amministratore delegato di Volvo, pubblica un documento intitolato “Educazione e competenze in Europa”[1], nel quale comincia a farsi strada l’idea che l’industria europea debba dare indicazioni ai governi sulle esigenze formative dell’impresa, in nome del mercato.
Nico Hirtt [2], esperto lussemburghese dell’argomento, cita i passaggi più significativi del volume, che verranno riecheggiati in tutti i documenti europei successivi, fino ad oggi: “Lo sviluppo tecnico e industriale delle imprese, vi si legge, esige chiaramente un rinnovamento accelerato dei sistemi di insegnamento e dei loro programmi“. L’ERTI lamenta che “l’industria non abbia che un’influenza molto debole sui programmi insegnati”, che gli insegnanti abbiano “una comprensione insufficiente dell’ambiente economico, degli affari, della nozione di profitto” e che essi “non capiscano i bisogni dell’industria”. Quindi, insiste la Tavola Rotonda, “competenza e educazione sono fattori di successo vitali”.
In conclusione, il potente gruppo di pressione padronale suggerisce di “moltiplicare i partenariati tra le scuole (e) le imprese”. Esso invita gli industriali a “prendere parte attiva allo sforzo per l’educazione” e chiede ai responsabili politici “di coinvolgere gli industriali nelle discussioni che riguardano l’educazione”.
È così che nel 1992 il trattato di Maastricht affida, con l’articolo 126, la competenza in materia d’istruzione alla Commissione europea, organo non elettivo. A tal fine viene creata la DGXXII, la Direzione generale dell’Educazione, della Formazione e della Gioventù, diretta dalla socialista francese Edith Cresson. Si tratta di una sorta di “ministero” europeo dell’Educazione. E poiché l’obiettivo polemico dell’ERTI era la “centralizzazione burocratica” dei sistemi scolastici nazionali, viene indicata la decentralizzazione come uno degli obiettivi principali da perseguire.
Seguono gli investimenti privati nell’istruzione, l‘introduzione delle nuove tecnologie informatiche, l’insistenza sulla flessibilità in uscita, la subordinazione della scuola al mondo del lavoro, l’insistenza sulle competenze, anziché sulle conoscenze, l’educazione permanente. In una società in tumultuoso cambiamento, la scuola deve cessare di essere il luogo della cultura, della tradizione, della formazione di teste pensanti e di cittadini responsabili e diventare il luogo liquido del continuo adattamento alle richieste dell’ambiente economico e della produzione di massa di manodopera a basso costo, docile rispetto alle richieste dell’impresa, oppure formata ad alto livello tecnico, ma poco consapevole dal punto di vista culturale. Una scuola duale, insomma, creata su misura per la competizione economica e per il risparmio delle imprese.
Nell’universo darwiniano dell’ideologia capitalista la parola d’ordine è deregolamentare, ovvero sottrarre al controllo dello Stato e mettere in concorrenza fra loro reti di realtà locali autonome. Nasce da qui l’autonomia scolastica, primo passo concreto verso la lenta, ma inesorabile distruzione della scuola pubblica, completata ora dal sinistro quanto sgangherato piano della Scuola 4.0.
Da quel documento del 1989 il lessico dell’istruzione si riempie di parole-chiave del linguaggio neoliberista, abilmente mascherate da innovazione e progresso: si parla di debiti e crediti, di standardizzazione, di successo formativo, di offerta formativa, di portfolio delle competenze, di dirigenti scolastici, di e-learning, di partnerariato pubblico-privato, di spirito imprenditoriale ecc.
Leggendo i documenti e constatandone l’esito effettivo, le parole d’ordine vanno per lo più intese al contrario: la lotta alla dispersione scolastica diventa il pretesto per politiche ancora più orientate alla gerarchizzazione della formazione; con la scusa dell’educazione permanente e della flessibilità si promuove la nascente industria europea del digitale e della formazione a distanza; con l’esaltazione delle competenze – più nel senso del verbo inglese to compete che di quello latino cum-petere – si svuota di contenuti l’insegnamento tradizionale. Il nuovo lavoratore dell’industria nel mondo globale deve essere flessibile in tutti i sensi: accettare qualunque lavoro e qualunque stipendio, adattarsi a orari e richieste di qualunque tipo, essere costantemente disponibile a formarsi, soprattutto a distanza, e a cambiare spesso lavoro.
Le risorse economiche per l’istruzione, che vanno opportunamente ridimensionate, devono essere indirizzate soprattutto alla digitalizzazione dell’insegnamento. Perciò, nel 1996 Jean-Louis Reiffers, che aveva collaborato l’anno prima con Edith Cresson alla stesura del famoso Libro Bianco “Insegnare e imparare: verso la società conoscitiva” [3], scrive: “È adattandosi alle caratteristiche dell’impresa dell’anno 2000 che i sistemi d’educazione e di formazione potrebbero contribuire alla competitività europea e al mantenimento dell’occupazione” [4].
Nel 2000, a Lisbona, si esalta l’e-learning come nuova frontiera dell’insegnamento e si tracciano gli obiettivi economici della futura “società della conoscenza”, nella quale la conoscenza è funzionale all’economia e alla competizione globale: l’ “obiettivo strategico fondamentale” dell’UE è “divenire l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita economica durevole, accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale”[5].

Alla scuola tradizionale, fondata sulla trasmissione intergenerazionale della cultura e sulla formazione della persona, si sostituisce progressivamente la scuola per l’impresa, fatta essa stessa impresa, nella quale si parla di competenze professionali (nelle nuove tecnologie informatiche, nelle lingue, nello spirito d’impresa, nella pluridisciplinarità) e sociali (“fiducia in se stessi, indipendenza, attitudine ad assumersi rischi” [6]), di formazione permanente (sviluppando le competenze di base e la capacità di imparare e facendo così risparmiare le imprese sulla formazione), di alfabetizzazione informatica e, come si è detto, di e-learning, di deregolamentazione e decentramento dei sistemi di istruzione nazionali, per renderli ” flessibili” e metterli in concorrenza fra loro, di partnerariato con le imprese (“Gli istituti scolastici, i centri di formazione e le università dovrebbero essere aperti sul mondo: è opportuno assicurare i loro legami con l’ambiente locale, con le imprese e con i datori di lavoro in particolare, per migliorare la comprensione dei bisogni di questi ultimi e accrescere in questo modo l’occupabilità dei discenti” [7]), di diversificazione dell’offerta, per venire incontro a bisogni diversi e “creare sistemi elastici di validità dei titoli” [8] (ovvero, indebolire il valore legale del titolo di studio, per aumentare la flessibilità e ridurre le tutele), di mobilità degli studenti (ottimo alibi per l’armonizzazione dei percorsi di studi e per un controllo europeo dell’insegnamento), di cittadinanza e impegno sociale (obiettivo che però poi tende ad indebolirsi nei documenti successivi) e di lotta all’esclusione, da attuare in tre modi: la sponsorizzazione delle scuole da parte di imprese, le convenzioni d’inserimento scuola-impresa (ecco lì l’alternanza scuola-lavoro), l’attuazione di tecnologie educative di punta [9].
Entra così nella mentalità comune l’idea strumentale e distorta che il fine dell’istruzione sia l’occupazione, che le competenze informatiche siano indispensabili per la scuola, addirittura fine e non semplicemente mezzo della didattica, che la precarietà (chiamata pudicamente “flessibilità”) sia una condizione “naturale” nel mondo del lavoro, che sia normale il condizionamento privato dell’istruzione pubblica e accettabile che siano gruppi di pressione privati e fondazioni aziendali o bancarie a suggerire le linee-guida dell’istruzione ad una classe politica sostanzialmente asservita al potere economico (chi non ricorda le patetiche “tre i” della berlusconiana ministra Letizia Moratti: Inglese, Informatica e Impresa?) e indifferente al destino della cultura e dell’educazione.
Dagli anni ’90 ad oggi il declino culturale della scuola si è accelerato fino al precipizio con la sequenza delle “riforme”: la riforma Moratti (2001), la riforma Gelmini (2008), la Buona scuola renziana (2015), le sciagurate e inutili misure pandemiche nella scuola, che hanno però permesso di condannare milioni di ragazzi alla DAD, fino all’epilogo tragico del PNRR, trionfo del nulla tecnologico e pietra tombale definitiva sulla scuola della Costituzione, della libertà di pensiero, del senso critico, della cultura umanistica e scientifica disinteressata, dell’arte e della bellezza. Soprattutto, cancellazione definitiva dello studente e della sua crescita umana e intellettuale come fine supremo dell’educazione.
Articolo di Patrizia Scanu
Per approfondire:
- Scanu, La perversione neoliberista e la legge della “Buona Scuola”
- Scanu, Ce lo chiede l’Europa? Le politiche scolastiche e la Costituzione neoliberista
- Scanu, Senza storia non c’è memoria. Salviamo l’insegnamento della storia
- Scanu, La scuola spolpata: il bilancio di vent’anni di riforme neoliberiste
- Scanu, Quale scuola per l’Europa che verrà?
- Scanu, Scuola, ultimo atto: quando la competenza scaccia la conoscenza
Note:
[1] European Round Table of Industrialists (1989), Education and European Competence: ERT study on education and training in Europe
[2] N. Hirtt, All’ombra della Tavola Rotonda degli industriali. La politica educativa della Commissione Europea. Traduzione a cura di Paola Capozzi. Extrait des Cahiers d’Europe, n°3, hiver 2000,
[3] CCE (1995), Libro bianco su Istruzione e Formazione. Insegnare e apprendere. Verso la società conoscitiva.
[4] Reiffers, J.-L. (1996), Accomplir l’Europe par l’éducation et la formation. Rapport / Commission européenne, Groupe de réflexion sur l’éducation et la formation.
[5] CCE (2000a), Comunicazione della commissione. E-learning: Pensare all’istruzione di domani.
[6] CCE (2000b), Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente.
[7] CCE (2001), Relazione della Commissione. Gli obiettivi futuri e concreti dei sistemi d’istruzione.
[8] Consiglio Europeo di Santa Maria da Feira (2000), Conclusioni della Presidenza: Occupazione, riforme economiche e coesione sociale.
[9] CCE (1995), Libro bianco su Istruzione e Formazione. Insegnare e apprendere. Verso la società conoscitiva.
Fonte: https://www.sovranitapopolare.org/2023/05/10/la-fine-della-scuola/