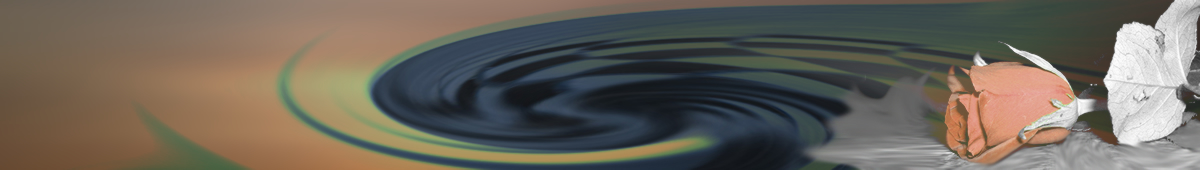di Flavia Corso
E’ tornata recentemente alla ribalta la discussione sull'”aborto post-natale”, l’ipotesi che non vi sia nulla di immorale nel praticare l’eutanasia su neonati disabili, e non solo.

Si potrebbe pensare ad uno scherzo di pessimo gusto, se non fosse che questa proposta non è affatto una novità nel panorama bioetico laicista. Uno dei primi sostenitori della moralità di questa pratica, è niente meno che Peter Singer, filosofo australiano tra i più influenti nell’ambito dell’etica contemporanea, nonché padre dell’antispecismo e, pertanto, sostenitore della liberazione animale.
Vero e proprio guru degli animalisti, comincia a trattare l’argomento negli anni ’70-’80. Oltre ad equiparare lo stato embrionale a quello fetale, prendendo in considerazione criteri come la razionalità, la consapevolezza e la capacità di provare dolore, si spinge oltre, affermando che non vi sarebbe alcuna differenza ontologica tra il feto e il neonato alle prime settimane di vita: in entrambi i casi, infatti, non si potrebbe parlare di “persona” nel vero senso del termine e, per questa ragione, il neonato – proprio come il feto – non avrebbe lo stesso diritto alla vita di un adulto.
A sostenere la causa infanticida in quegli anni, vi è anche il filosofo americano Michael Tooley che, nel 1972, pubblicava l’articolo “Abortion and infanticide”, per il quale né il feto né il neonato soddisfano i requisiti per poter essere considerati persone degne di reclamare il loro diritto alla vita. Nel 2012, sul “Journal of Medical Ethics”, compare un articolo dal titolo “After-birth abortion: why should the baby live?” di Alberto Giubilini e Francesca Minerva. I due ricercatori italiani sostengono che lo status morale di un neonato sia del tutto equivalente a quello di un feto, motivo per cui né l’uno né l’altro sarebbero in possesso dei criteri per essere considerati “soggetti con un diritto morale alla vita”, ragion per cui il termine “aborto post-natale” sarebbe da considerarsi preferibile rispetto a “infanticidio”.
 In sostanza, per i due studiosi “uccidere un neonato dovrebbe essere permesso in tutti i casi in cui lo è l’aborto, inclusi quei casi in cui il neonato non è disabile”. A difendere le farneticazioni di Giubilini e Minerva, che hanno giustamente scatenato una serie infinita di polemiche, si schiera anche Maurizio Mori, professore di bioetica presso l’Università degli Studi di Torino e presidente della Consulta di Bioetica Onlus, di cui Beppino Englaro è socio onorario. Secondo Mori, l’ipotesi dell’infanticidio non sarebbe da scartare a priori, “solo perché scuote sentimenti profondi e tocca corde molto sensibili”, ma bisognerebbe invece prenderla in considerazione con serenità, senza porre limiti alla libera ricerca scientifica.
In sostanza, per i due studiosi “uccidere un neonato dovrebbe essere permesso in tutti i casi in cui lo è l’aborto, inclusi quei casi in cui il neonato non è disabile”. A difendere le farneticazioni di Giubilini e Minerva, che hanno giustamente scatenato una serie infinita di polemiche, si schiera anche Maurizio Mori, professore di bioetica presso l’Università degli Studi di Torino e presidente della Consulta di Bioetica Onlus, di cui Beppino Englaro è socio onorario. Secondo Mori, l’ipotesi dell’infanticidio non sarebbe da scartare a priori, “solo perché scuote sentimenti profondi e tocca corde molto sensibili”, ma bisognerebbe invece prenderla in considerazione con serenità, senza porre limiti alla libera ricerca scientifica.
A fine agosto di quest’anno, Joona Räsänen – bioeticista finlandese presso l’Università degli Oslo – torna sul tema, difendendo la moralità dell’infanticidio, in un articolo all’interno della rivista “Bioethics”, dal titolo “Why pro-life arguments still are not convincing: a reply to my critics”. Räsänen si era già espresso in merito alla questione nel 2016, sostenendo la tesi di Giubilini e Minerva. Questa volta, però, l’argomento utilizzato per giustificare l’infanticidio da un punto di vista morale, è incredibilmente bizzarro: secondo Räsänen, le persone avrebbero il diritto alla loro privacy genetica, e il fatto che il neonato sia portatore del materiale genetico dei genitori naturali violerebbe la privacy genetica di questi ultim. Mettendo sullo stesso piano il diritto alla vita e il diritto alla privacy, quindi, Räsänen rivendicherebbe in linea teorica il diritto dei genitori di uccidere i loro figli appena nati.
Il mito contemporaneo dell’illimitatezza dell’agire umano e la naturalezza con cui si ipotizzano scenari inquietanti sembrano dunque permeare pericolosamente la bioetica laicista che, tuttavia, potrebbe ormai a pieno titolo prendere il nome di “bioetica omicida”.
Articolo di Flavia Corso