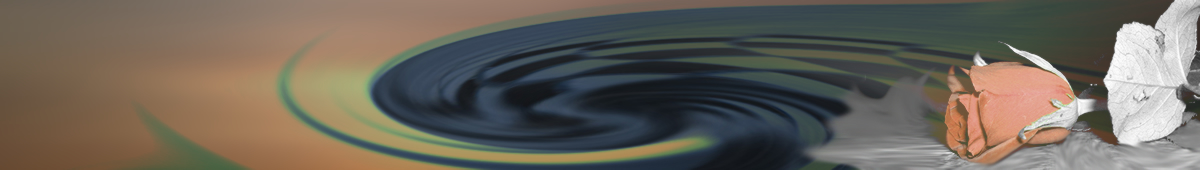di Salvatore Bonfiglio
Negli Usa l’incidenza della “work addiction” è del 10 per cento, di poco inferiore alla dipendenza da nicotina e paragonabile a quella dall’alcol.

“Mi dica… signor Felice… qual è il suo problema?”
“Il problema è che non vedo l’ora che arrivi lunedì”.
“Non capisco… Si spieghi meglio”.
“Dottore… Sento sempre amici e colleghi che odiano il lunedì perché inizia una nuova settimana di lavoro. Ebbene, io non vedo l’ora che arrivi lunedì perché riprendo a lavorare. Io amo lavorare. Il lavoro è come l’aria che respiro, ne ho bisogno”.
Il signor Felice è un paziente che ho incontrato presso il mio studio ed è affetto da una forma di dipendenza di cui si comincia a discutere sempre di più ultimamente, cioè la dipendenza da lavoro, anche detta workaholismo, work addiction o excessive working (Andreassen, 2013).
Per quanto se ne cominci a parlare adesso, il fenomeno del work addiction è conosciuto già da tempo e la letteratura scientifica, soprattutto negli ultimi anni, è notevolmente aumentata. Vengono riportate diverse tipologie di work addicted: il bulimico, che deve fare tutto, spesso troppo, e bene; l’inarrestabile, guidato dagli obiettivi e dalle scadenze e che non riesce mai a fermarsi; o quello con deficit-attentivo, che si agita facilmente, che si impegna in un’infinità di progetti ed è continuamente spinto da nuove sfide.
Secondo una recente ricerca (Sussman e altri, 2011), che ha analizzato la prevalenza di molte forme di dipendenza e co-dipendenza negli Stati Uniti, sembra che l’incidenza della dipendenza da lavoro è di poco inferiore a quella per la nicotina e paragonabile a quella dell’alcol, cioè si attesta intorno al 10 per cento. Un dato preoccupante, soprattutto se si pensa alle differenti configurazioni, dal punto di vista sociale e professionale, che questa forma di dipendenza assume rispetto alle altre e più conosciute forme. La società, infatti, tende a rinforzare, incentivare e gratificare chi lavora di più; chi si prodiga nel proprio lavoro è visto come esempio da seguire.
“Come mai lavora così tanto?”
“Sono un libero professionista, non posso permettermi di perdere un nuovo lavoro… Non si sa mai… In questi momenti di crisi. E poi, ai miei figli non deve mancare niente. Io voglio che venga soddisfatto ogni loro desiderio”.
È la dipendenza del “non-dipendente”. Non per niente i settori più colpiti sono i liberi professionisti (come il signor Felice), i manager, gli artigiani e i commercianti. Difficilmente una persona ritorna a lavoro dopo aver timbrato il cartellino d’uscita! Molti autori ritengono che un workaholista si riconosca in quanto dedica 50 o più ore a settimana al lavoro. Questo indicatore è comunque molto controverso anche perché, spesso, molte persone lavorano tanto o hanno più lavori per necessità economiche e non per un’effettiva dipendenza.
La quantità di ore settimanali non è quindi l’unica discriminante. Vanno considerati anche aspetti psicologici, emotivi e comportamentali, soprattutto perché nel workaholista il lavoro diventa spesso un modo per gestire emozioni e sensazioni negative, come ansia e colpa, che emergono quando non lavora. Inoltre, alla quantità di ore dedicate e alla forte dedizione non si accompagnano spesso un’altrettanta buona prestazione professionale o qualità del lavoro: troppe cose da fare e sempre troppo poco tempo per farle bene!
“Riesce a riposare nel fine settimana, visto il tanto lavoro? La sera dorme… Sogna?”
“Dormo poco, perché sono sempre con la testa lì, a cercare di risolvere problemi e a trovare soluzioni. Mi piace trovare soluzioni. Mi eccita! Sono sempre con il cervello in movimento. Penso che riposare sia inutile. Non serve a niente! Come divertirsi. Pensi a tutti quei giovani che pensano solo a divertirsi, ad andare ai concerti o a passare le serate a bere birra, al cinema … pensi a quanto tempo perdono. È tutto tempo perso! Anch’io alla loro età facevo lo stesso, ma mi rendo conto solo adesso di quanto tempo ho perso e che potevo utilizzare facendo altro, come studiare e imparare cose nuove. Se solo ci ripenso”.
“Quindi non fa nient’altro nella vita. Voglio dire, non ha hobby, passioni e interessi oltre al lavoro?”.
“Una volta ero appassionato di equitazione. Avevo dei cavalli. Li curavo. È una passione che mi ha trasmesso mio padre. Ma qualche hanno fa ho venduto i cavalli. Troppo lavoro, troppi impegni. Non riuscivo a curarmi più di loro ormai, ed ero sempre occupato e il tempo l’ho dedicato sempre più a lavorare. Poi, con mia moglie, andavamo spesso a ballare il tango la sera. Eravamo bravi. Ma col tempo, anche questo, l’abbiamo abbandonato. Andavamo la sera, ma sa adesso con i figli… Lei mi capisce vero?!”.
 È un comportamento autodistruttivo: la persona dipendente dal lavoro mette in secondo piano la propria vita familiare e privata, è incapace di regolare le proprie abitudini di lavoro e arriva al punto di escludere le altre attività della vita (Robinson, 1998). In questo, ha molto in comune con le altre forme di dipendenza: la perdita di controllo, la presenza di craving (desiderio irresistibile di assumere una sostanza), ad esempio, e il fatto che il comportamento dipendente arrivi a interferire con la vita privata, con i propri interessi e con la vita sentimentale e familiare.
È un comportamento autodistruttivo: la persona dipendente dal lavoro mette in secondo piano la propria vita familiare e privata, è incapace di regolare le proprie abitudini di lavoro e arriva al punto di escludere le altre attività della vita (Robinson, 1998). In questo, ha molto in comune con le altre forme di dipendenza: la perdita di controllo, la presenza di craving (desiderio irresistibile di assumere una sostanza), ad esempio, e il fatto che il comportamento dipendente arrivi a interferire con la vita privata, con i propri interessi e con la vita sentimentale e familiare.
“E come va con sua moglie?”
“Mi sopporta, è una santa! Non so come riesca, visto che sono sempre di cattivo umore e scorbutico. Rido poco. Lei si dedica a me e non dice niente se la sera rimango sveglio a lavorare e la mattina ho giusto il tempo di bere un caffè e dare un bacio ai bimbi, prima di rimettermi in macchina e uscire. Anzi, ha preso il part-time per poter stare di più con i figli e badare alle faccende familiari, e mi permette così di lavorare più tranquillo durante la settimana”.
“Ma la vostra vita affettiva. La vostra intimità. Come sono?”.
“Ci vogliamo bene. Molto bene. Siamo affezionanti. Non saprei come fare se non ci fosse lei”.
“E sua moglie cosa pensa? Cosa dice?”.
“Mi ama. Cerca di distrarmi organizzando qualche gita in famiglia. E fa bene. Forse certe volte esagero lavorando troppo. Dovrei dedicare più tempo a loro”.
Il signor Felice non sembra rientrare ancora in quel 65% di popolazione – di work addicted – che arrivano a separarsi. È spesso il coniuge (che si sente come la “seconda scelta” dopo il lavoro) a chiedere aiuto e a spingere il partner a chiedere aiuto, proprio nel tentativo di salvare la vita familiare o la relazione con il partner. Inoltre, le conseguenze, in molti casi, non ricadono solo sul coniuge ma anche sui figli, che si trovano costretti a vivere quotidianamente la condizione di co-dipendente, sacrificando spesso la propria vita privata, relazionale e affettiva.
“Come mai ha deciso di contattarmi, di chiedere aiuto. L’ha spinta qualcuno o è una scelta volontaria e consapevole?”
“Dottore, io il problema non lo vedo molto. Ma vedo gli altri. La maggior parte delle persone non è come me, non vive per lavorare, semmai lavora per vivere. Io, forse, devo capire un po’ di cose e vorrei che lei mi aiutasse a capirle. A capire come comportarmi. Cosa è meglio fare. Come migliorare il mio umore in famiglia. Vorrei essere più sereno. Più sereno con loro”.
Le considerazioni del signor Felice fanno ben sperare nell’efficacia di un trattamento psicoterapeutico. Innanzitutto per la scelta autonoma (cioè non spinta da altri) nel chiedere aiuto e per la quota di consapevolezza che ha rispetto al problema. Ma non per molti è così! Per quanto riguarda la cura, la letteratura considera efficace la psicoterapia, soprattutto se aiuta a enfatizzare le risorse resilienti e le qualità positive del lavoratore. Se focalizza l’attenzione sulle capacità del dipendente di prendersi cura di sé, sulla gestione del tempo e la sua qualità e sull’equilibrio fra lavoro e vita privata-sociale. Altrettanto efficace sono il programma a 12-step dei “Workaholisti Anonimi” o le attività di rilassamento e gestione dello stress.
“Ma mi dica la verità, dottore … sono malato?”
Il dubbio del signor Felice è fondato. Il workaholismo ha una sua “diagnosi” con sintomi e segni comportamentali tipici di un disturbo ossessivo-compulsivo. Ma siamo molto lontani dal vedere riconosciuta al workaholismo un’etichetta in una delle prossime edizioni del DSM, così come è successo per la più “fortunata” dipendenza da gioco d’azzardo o gambling. La letteratura scientifica le dedica, per adesso, un discreto interesse nel campo delle dipendenze. Dovrebbe però avere un riconoscimento maggiore essendo così profondamente intrecciata con la cultura occidentale e con una società prestazionale; e anche per l’importanza che assume il lavoro come status sociale. Per questi e altri motivi andrebbe trattata e affrontata non solo come una dipendenza psicologica ma anche e soprattutto come un problema sociale, fortemente legata a uno stile di vita culturalmente determinato e appreso.
Articolo di Salvatore Bonfiglio – Psicologo e psicoterapeuta. Direttore scientifico di Fondazione Eris. Dottore di ricerca, Docente di psicologia all’Università degli studi di Pavia.